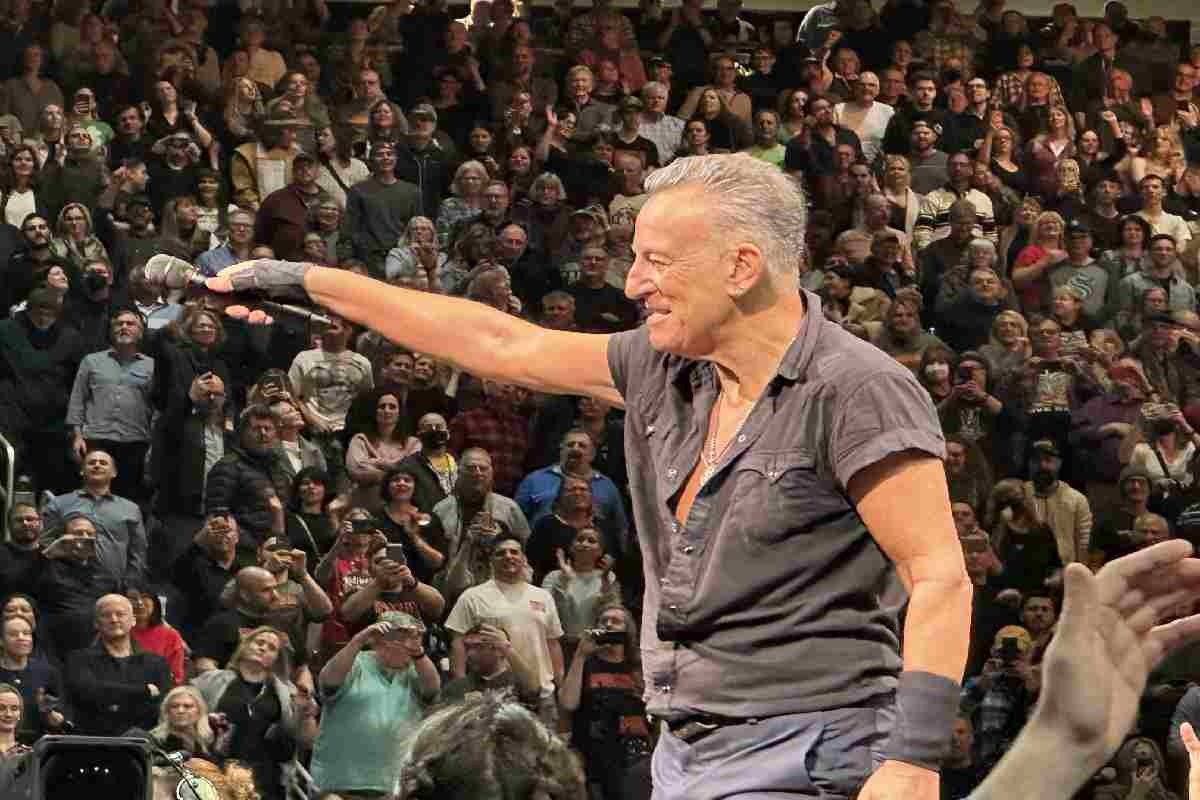Quando nel 2018 Donald Trump annunciò l’imposizione di dazi su acciaio e alluminio, alcuni esperti etichettarono la mossa come una svolta protezionista senza precedenti. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che l’approccio di Trump, tornato di prepotenza durante il suo secondo mandato, non è affatto un’innovazione, ma piuttosto un ritorno a una pratica storica ben consolidata negli Stati Uniti. Fin dai tempi della Grande Depressione, l’America ha spesso fatto ricorso ai dazi doganali come strumento per proteggere l’industria nazionale e sostenere l’occupazione. In periodi di crisi economica o di transizione, i leader americani hanno utilizzato i dazi come una sorta di scudo contro la concorrenza estera, cercando di stimolare la produzione interna e salvaguardare i posti di lavoro.
La retorica protezionista ha trovato terreno fertile in un’epoca di crescente globalizzazione, in cui molti americani si sono sentiti minacciati dalla delocalizzazione e dalla perdita di posti di lavoro. I dazi sono stati presentati come una risposta diretta a queste preoccupazioni, promettendo di riportare l’industria manifatturiera negli Stati Uniti e garantire un futuro più sicuro per i lavoratori americani.
Tuttavia, le conseguenze delle politiche sui dazi non sono state prive di critiche. Molti economisti avvertono che l’uso dei dazi può portare a ritorsioni da parte di altri Paesi, aumentando i costi per i consumatori e danneggiando le relazioni commerciali internazionali. La questione dei dazi è anche legata all’identità nazionale e al modo in cui gli Stati Uniti si pongono nel contesto globale. Per comprendere come si è arrivati all’uso attuale di questo strumento economico e politico, è doveroso ripercorrere la storia degli Usa, soffermandosi sui presidenti che, proprio come Trump, hanno fatto un uso massiccio dei dazi.
Herbert Hoover e la Grande Depressione
Herbert Hoover, presidente degli Stati Uniti dal 1929 al 1933, è spesso ricordato come una figura controversa nella storia economica americana, soprattutto per il suo ruolo durante la Grande Depressione. La sua amministrazione fu segnata dall’approvazione della legge Smoot-Hawley nel 1930, un provvedimento che mirava a proteggere l’industria nazionale attraverso un aumento senza precedenti dei dazi su oltre 20.000 prodotti importati. Questa decisione, sebbene motivata dalla volontà di sostenere l’economia americana in un momento di crisi, si rivelò controproducente. Infatti, la legge scatenò una reazione a catena di misure protezionistiche da parte dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, come il Canada e diverse nazioni europee, che risposero con tariffe reciproche. Questo scambio di colpi tariffari non solo intensificò la crisi economica, ma contribuì anche a un clima di sfiducia e isolamento commerciale che avrebbe avuto ripercussioni durature.
Le conseguenze furono devastanti: il commercio internazionale subì un crollo senza precedenti, aggravando la disoccupazione e la povertà in un periodo già critico. La figura di Hoover, inizialmente vista come un leader competente e un uomo d’affari di successo, si trasformò rapidamente in quella di un presidente incapace di affrontare le sfide economiche del suo tempo. La sua eredità è quindi complessa, segnata da buone intenzioni ma da risultati disastrosi, e continua a essere oggetto di dibattito tra storici ed economisti.
La legge Smoot-Hawley è diventata un simbolo di come le politiche protezionistiche possano, in tempi di crisi, aggravare ulteriormente le difficoltà economiche anziché risolverle.
McKinley, l’antesignano del protezionismo
William McKinley, presidente degli Stati Uniti dal 1897 al 1901, è spesso ricordato come un pioniere del protezionismo economico, un tema che ha riempito le pagine della storia americana ben prima dell’era di Herbert Hoover. La sua influenza si fece sentire già nel 1890, quando promosse la tariffa che porta il suo nome, un provvedimento che mirava a tutelare l’industria nazionale in un periodo di rapida industrializzazione. McKinley credeva fermamente che l’imposizione di dazi doganali fosse essenziale per proteggere i posti di lavoro e stimolare la produzione interna, un approccio che rispecchiava le preoccupazioni di un’America in trasformazione. Gli industriali, in particolare, accolsero con entusiasmo le sue politiche, vedendo in esse un’opportunità per rafforzare la propria posizione nel mercato globale.
Tuttavia, il lato oscuro di queste misure si manifestò rapidamente: i consumatori si trovarono a fronteggiare un aumento dei prezzi, poiché i dazi resero più costosi i beni importati. Questo contrasto tra gli interessi delle classi produttive e quelli dei consumatori alimentò un dibattito acceso, che continua a essere attuale anche nei giorni nostri.
I dazi come strumento di sviluppo
Nel contesto della storia economica americana, l’approccio di Ulysses S. Grant al protezionismo offre spunti di riflessione sul ruolo dei dazi come strumento di sviluppo. Dopo la devastazione della guerra civile, Grant comprese che la rinascita dell’industria nazionale era fondamentale per il futuro del paese. La sua politica protezionista mirava a proteggere le giovani industrie americane dalla concorrenza estera, creando un ambiente favorevole alla crescita economica interna. La celebre affermazione di Grant, secondo cui l’America avrebbe potuto abbracciare il libero scambio solo dopo aver sfruttato appieno i benefici del protezionismo, risuona con particolare rilevanza nel dibattito contemporaneo.
Lincoln e Jackson: dazi e conflitti interni
La storia americana è costellata di momenti in cui le politiche fiscali hanno acceso tensioni interne, e due presidenti emblematici, Abraham Lincoln e Andrew Jackson, si trovano al centro di queste dinamiche. Durante la Guerra Civile, Lincoln si trovò a dover affrontare non solo il conflitto armato, ma anche la necessità di sostenere l’economia del Nord. Per questo motivo sostenne un aumento delle tariffe, una mossa strategica per proteggere l’industria emergente e, al contempo, finanziare lo sforzo bellico. I dazi rappresentavano la principale fonte di entrate per il governo federale, un aspetto cruciale in un periodo di crisi. Tuttavia, l’implementazione di tali misure non fu priva di conseguenze.
Negli anni Trenta dell’Ottocento, la cosiddetta “Tariffa delle abominazioni” del 1828 scatenò una reazione violenta nella Carolina del Sud, dove i leader locali minacciarono di annullare la legge federale, dando vita a una delle crisi più significative della storia americana: la “crisi della Nullificazione“. Andrew Jackson, presidente in quel periodo, non si lasciò intimidire. Con una determinazione ferrea, riaffermò l’autorità del governo centrale, sottolineando l’importanza dell’unità nazionale e il pericolo rappresentato da tali tentativi di disobbedienza.
Tradizione o ritorno al passato?
Negli ultimi anni, il dibattito sul protezionismo ha riacquistato vigore negli Stati Uniti, con Donald Trump che ha riportato i dazi al centro della scena politica. Questo fenomeno non è una novità, ma piuttosto un ritorno a una strategia economica che ha radici profonde nella storia americana. La differenza principale rispetto al passato risiede nel modo in cui queste politiche vengono comunicate e percepite dal pubblico, grazie all’influenza dei social media e di un’informazione sempre più immediata. Mentre in passato il protezionismo era spesso visto come una misura necessaria per proteggere l’industria nazionale, oggi è accompagnato da un linguaggio più aggressivo e da una retorica che polarizza l’opinione pubblica. Tuttavia, la sostanza delle politiche rimane invariata: quando l’economia mostra segni di rallentamento e il consenso politico inizia a vacillare, i leader tendono a rispolverare l’arma del protezionismo. Questo ciclo di alti e bassi è emblematico di una nazione che, pur essendo proiettata verso il futuro, non riesce a liberarsi completamente dalle sue tradizioni economiche. La questione si complica ulteriormente quando si considera l’impatto globale di tali scelte; le politiche protezionistiche non solo influenzano l’economia interna, ma hanno anche ripercussioni significative sulle relazioni commerciali internazionali.